L’arte è una questione di libertà, non di genialità.
Damien Hirst
Una fotografia è davvero buona non quando è vista con piacere, ma quando viene ricordata. Può esserlo per la sua valenza narrativa, per la forza evocativa o per la perfezione formale. Tecnicamente, anche una brutta foto può essere buona se soddisfa uno di questi tre requisiti. Meglio se ne soddisfa due, o addirittura tutti e tre, anche se è raro che un’immagine formalmente “perfetta” riesca pure ad essere emozionante, e viceversa. Sbaglieremmo tuttavia a contrapporre come fossero valori antitetici concetti quali il rispetto delle regole e la libertà espressiva.
Quale che sia il registro, il genere, lo stile, il linguaggio, credo che una fotografia debba sempre misurare il proprio valore attraverso dei parametri condivisibili, se non vuole restare il classico “scarrafone bello a mamma sua”, ed è attraverso questi stessi parametri che una fotografia può essere letta e valutata dal suo fruitore. La quantità e la definizione di tali parametri sono ineluttabilmente soggette ai molteplici, cangianti destini del gusto. Come tali, affidati allo Zeitgeist, lo “spirito del tempo”, alle mode, o, ahinoi, alla forza persuasiva di qualche critico o gallerista particolarmente influente.
I parametri “oggettivi” sono semplici e noti, li troviamo in ogni manuale di fotografia, dal Feininger (1) in giù, e non è il caso di ripeterli qui. La rete è piena di decaloghi della buona composizione, presentati come la pietra filosofale del fotografo di successo o, al contrario, come catene dalle quali liberarsi per poter considerarsi veri artisti... Non fa mai male dare una ripassata a queste regole, ma non è lo scopo di questo articolo, vista anche la loro facile reperibilità. Quel che voglio fare qui è condividere i miei personali percorsi di valutazione di una fotografia, i quali, pur appoggiandosi agli strumenti tradizionali della critica fotografica, li usano e li interpretano in maniera del tutto soggettiva, com’è giusto che sia.
Queste note non rappresentano dunque l’ennesimo manualetto della composizione e fruizione fotografica, ma solo uno spunto di riflessione, per nulla esaustivo, tratto da competenze variamente acquisite, dallo studio dei maestri e, soprattutto, dalla mia esperienza. Pensieri messi a disposizione di chi voglia confrontarsi con questo approccio ed entrarvi in dialettica, proponendo le proprie esperienze e le proprie personali modalità di lettura e valutazione. Così che questo piccolo scritto, alla fine, arricchito del contributo di chi lo desideri, diventi uno spaccato di “intelligenza visiva” collettiva, in continua espansione.
Le regole fondamentali della fotografia riguardano due semplici parametri: l’esposizione e la messa a fuoco. Indovinare la corretta coppia tempi/diaframmi e la giusta distanza tra soggetto e punto di ripresa è tutto ciò che serve per restituire piena visibilità alle aree dell’immagine considerate fondamentali, conferendo loro la massima nitidezza possibile in una determinata condizione di luce. Quel che fa con naturalezza qualunque apparecchio automatico, e persino qualunque telefonino dotato di fotocamera.
Basterebbe questo per capire come la “correttezza” di una fotografia interessi davvero poco a fotografi appena un poco smaliziati, come certamente sono gli amici di forum che stanno leggendo queste note. Anzi, conoscendo la passione che molti di noi hanno per i mossi, gli sfuocati, le alteluci avvolgenti e i neri impenetrabili, potremmo quasi dire che la ricetta di una buona foto consiste proprio nella capacità di trasgredire in modo consapevole queste due regole fondamentali.
Regole che sono abbastanza semplici da gestire. Esse si muovono su parametri puramente quantitativi: misura della sovra o sottoesposizione e regolazione della distanza di messa fuoco. Appena cominciamo a parlare di composizione, invece, siamo costretti ad abbandonare i criteri dell’algebra elementare. Stabilire la quantità e la natura delle informazioni da inserire all’interno del fotogramma prescelto (rettangolo o quadrato che sia) è infatti un’operazione aperta a infinite soluzioni, tante e tali sono le variabili a nostra disposizione.
Se fossimo dei o avessimo a disposizione un “panopticon”, in grado di vedere tutto l’universo con un colpo solo, non avremmo nessun imbarazzo della scelta. Ma non siamo dei e non disponiamo di un simile strumento, è per questo che ci divertiamo così tanto a fotografare: ci tocca esercitare una libera determinazione mirata a delimitare una porzione di mondo percepito in uno spazio dato, e la cosa è tanto complessa quanto affascinante.
La prima operazione è definire tale spazio. Quadrato o rettangolare, nei nostri standard, con diverse proporzioni tra i lati (3:2; 4:3; 6:7; panoramico, ecc.) e con due orientamenti possibili (verticale o orizzontale). La scelta del formato è fondamentale per orientare il nostro processo compositivo; riempire un quadrato non è la stessa cosa che riempire un rettangolo, cambiano le forze vettoriali, le spinte gravitazionali, le relazioni spaziali tra le linee e le masse. Il formato orienta pure la lettura della fotografia: basti pensare al verso col quale siamo soliti leggere un’immagine all’interno di una cornice rettangolare (da sinistra a destra solitamente, almeno nella nostra cultura), che però diventa dall’alto al basso nel caso in cui la cornice sia verticale, specie se stretta. Più sofisticate e complesse le dinamiche percettive all’interno del formato quadrato.
Cito dal mio libricino “Di lemmi fotografici” (2):
Il formato è il presupposto sul quale va a svilupparsi il gesto visivo. Va scelto prima dello scatto, non dopo. Gli aggiustamenti sono sempre ammissibili, ma non devono essere dati a vedere. Ecco perché amo i formati tradizionali (va da sé che aborro la commistione di formati diversi all’interno di una stessa serie).
Il formato è la cornice, il limite, il perimetro entro cui gestire la libertà espressiva, ma è anche un modo di concepire lo spazio, di riempirlo e di abitarlo. Il rettangolo è dinamismo, linearità, progressione temporale; la percezione al suo interno segue precisi, predefiniti moti vettoriali, con una forza, una direzione e un verso, a partire da un punto di applicazione. Il quadrato è più complesso, direi più aristocratico. Al suo interno trovano posto anche le leggi del moto circolare, tempo e movimento possono fermarsi, se lo vogliono, e la disposizione degli elementi nello spazio tracima le imposizioni della gravità, creando geometrie più ampie, imprevedibili e meno codificate, dove, come nel sogno freudiano, le adiacenze spaziali creano originali nessi causali. Il rettangolo è una vasca di pesci rossi, dove vedi il tempo scorrere avanti e indietro, segui le storie con un verso narrativo dato, senza mai sovvertire le regole della fisica classica. Il formato quadrato segue una logica quantistica, un sistema a “n” gradi di libertà (quanti il fotografo è in grado di concepirne). In una foto rettangolare c’è un mondo, dentro una foto quadrata c’è l’universo.
Ci vuole una grazia particolare per utilizzare come si deve il formato quadrato, oppure una generosa follia: quando fai una bella foto rettangolare ti senti un artista; quando fai una bella foto quadrata, puoi sentirti Dio.
Il formato detta quindi il verso della lettura. Essa tuttavia non parte, come per il testo, necessariamente dall’estremo sinistro. La lettura di un’immagine ha bisogno di un point de repère ben riconoscibile da cui far partire il processo visivo. Questo vale per le immagini a forte valenza narrativa quanto per quelle più astratte: occorre un punto a cui “agganciare” il processo visivo, pena una sensazione di sperdimento e confusione che rischia di mal disporre lo spettatore e danneggiare la fruizione della fotografia.
Occorre poi una “punteggiatura”, che detti il ritmo, le pause, la velocità dell’incedere, che insomma costituisca il “respiro” della foto. È sempre valida la regola del less is more, immagini essenziali, con un numero ridotto di informazioni, respirano indubbiamente meglio di altre piene zeppe di elementi. Ma anche immagini più sature possono avere un buon respiro, a patto che la punteggiatura sia efficace.
Va da sé, lo dico adesso ma potrei ripeterlo per ogni concetto, che lì dove sia proprio il senso di “soffocamento” il sentimento che desideriamo rappresentare o evocare, un certo “asma percettivo” diventerà un valore aggiunto, così come, viceversa, lo sarà l’”anossia visiva” lì dove l’obiettivo sia ispirare un senso di solitudine e di rarefazione. Siamo nel campo dell’uso creativo dei parametri, al fine di generare emozioni. Ma nulla, a mio avviso, nemmeno l’uso più spregiudicato e “artistico” delle regole può giustificare gli eccessi di confusione. La percezione umana ha le sue caratteristiche e le sue esigenze, ed è all’interno di un preciso quadro “grammaticale” di riferimento che le regole possono essere rimescolate. Espandere quel quadro non dico sia impossibile, ma è prerogativa di pochi, e succede in rari momenti di grazia.
Come funziona la nostra percezione? Non mi riferisco alla struttura dell’occhio, la retina, i coni e i bastoncelli, parlo delle funzioni organizzative del percetto. Il nostro "apparato per vedere" organizza ogni volta che può, come può, le immagini in unità fenomeniche coerenti. Le leggi che regolano l’organizzazione del campo visivo, individuate dai teorici della Gestalt (3), sono: vicinanza, somiglianza, continuità di direzione, chiusura, pregnanza, destino comune e esperienza passata. La cultura dell’osservatore consente di individuare nelle strutture visive unità sempre più complesse, efficaci, esteticamente significative e originali. La nostra mente individua grafemi a partire dai più semplici (segmenti, cerchi, triangoli, quadrati...) e in quelli riconosce delle "buone forme", oppure individua facili legami associativi tra le parti, risultando appagata dall’esito di tali rideterminazioni formali. Compito dell'arte è trovare nuove configurazioni, sovvertire stilemi, inventare inedite dinamiche visuali. Sapendo, tuttavia, che ogni volta che oltrepassiamo il limite delle regole della buona forma ciò dev’essere giustificato da una adeguata cornice di senso. Essa dev’essere rintracciata all’interno di un riconoscibile percorso creativo, personale dell’autore o relativo ad una determinata corrente stilistica. Ci sono opere, anche molto famose e molto quotate (penso a autori come William Eggleston, Thomas Struth, Andreas Gursky, Cindy Sherman, Edward Steichen, Jeff Wall…), che difficilmente sarebbero considerate di qualche rilevanza se considerate al di fuori di tali cornici artistiche (e commerciali). Restiamo in casa nostra, cito il grande Luigi Ghiri: pensate che senza un sofisticato impianto teorico e un coerente percorso visuale le sue fotografie, prese a se stanti e di primo acchito, potrebbero mai appagare l’occhio dell’osservatore ed essere considerate le opere d’arte che sono, apprezzate e collezionate in tutto il mondo?
Ecco perché occorre “cultura” per valutare appieno un’immagine. Non una cultura accademica e paludata, ma una capacità di vedere oltre, di scorgere linee invisibili all’interno di una proposta visiva che può piacere o meno, ma di cui dobbiamo cercare per quanto possibile di decodificare il senso. Come dico spesso, non abbiamo bisogno di belle foto (quelle possono capitare a tutti qualche volta nella vita), ma di riconoscibili percorsi di senso, che possano diventare filtri autoriali per interpretare la vita. All'interno di questi percorsi le fotografie acquistano un significato, facendosi parte di un puzzle coerente, senza la cui visione generale i singoli tasselli rischierebbero di risultare insignificanti.
Le regole “ortografiche”, dicevamo, consentono una corretta lettura dell'immagine. Ma esse non tengono davvero conto di tutte le forze in gioco. Vettori e direttrici rappresentano dinamiche percettive interne agli elementi che ci sono, ma non dicono nulla di ciò che non c'è e che pure grava in modo significativo sulla forza evocativa dell'immagine. La fotografia non è mai pura emanazione del referente, in essa è importante ciò che c’è ma anche ciò che non c’è. L’immagine completamente satura, dove tutto è dato, non lascia posto all’immaginazione. La fotografia d’autore contiene quasi sempre un sottile “fuori campo”, uno sfuocato, un elemento di indeterminatezza o di mistero. Questa lieve sfuocatura dà la possibilità di travisare e consente l’espansione dei significati. Il desiderio di essere circostanziati ed esaustivi può invece condurre a saturare lo spazio mentale, producendo delle mere rappresentazioni tautologiche. Siamo allora nel campo della “pornografia”, una bellezza esibita ma infeconda, dimenticabile dopo il tempo di un “mi piace”. L’immagine non vive nella mente del fruitore, scompare dopo pochi secondi dalla sua apparizione.
Potremmo pensare che il reportage, la fotografia di testimonianza, debba per sua natura essere esaustivo sul versante rappresentativo, mostrare tutto, non lasciare nulla fuori campo. Sbaglieremmo, secondo me. Nella nostra epoca il reporter non ha più il compito precipuo di informare e mostrare verità, stante che qualunque media trasmette h. 24 immagini di ogni situazione, da ogni luogo del pianeta. Compito del fotoreporter oggi è piuttosto quello di incuriosire, suscitare emozione ed interesse verso un dato evento, stimolando nel pubblico la voglia di approfondirlo. A questo serve l’immagine fotografica, e il fine ultimo di “reporter” e “artisti” non è più così distante come ai tempi di Alfred Stieglitz: si tratta, in entrambi i casi, di compiere esplorazioni del proprio mondo, interno ed esterno, alla ricerca di punti di vista sulla vita e su se stessi.
Come tenere conto di questa “insaturità” dell’immagine? Fino a che punto può spingersi questa insaturità? Com’è ovvio, non si tratta di un parametro che si possa misurare attraverso l’utilizzo di criteri oggettivi, ma non c’è dubbio che quel che non è compreso nel fotogramma intervenga a determinare la valenza di una fotografia in maniera persino più incisiva di quanto invece è ben visibile.
Ripesco un altro brano dal mio libro per fornire un esempio, utilizzando un’analogia di tipo testuale:
Supponiamo di voler fare un esame fonetico, metrico, volumetrico e semantico del seguente engramma:

Sul piano ortografico possiamo scomporre il testo in blocchi, individuare un unico volume, due volumi sillabici speculari o le quattro singole lettere, tracciare un vettore rettilineo orizzontale sinistra → destra, invertirlo evidenziando la natura palindroma della parola, definire forze gravitazionali centrifughe e centripete, a chiudere verso le zeta o ad aprire verso le vocali periferiche.
Ma su tutto questo prevarrà sempre e comunque la "parte mancante", quella prima lettera che la nostra esperienza collocherà automaticamente a configurare una qualche gestalt nota. Questa lettera mancante definirà l'intero contesto, mutando radicalmente il significato dell’intero blocco a seconda che sia una P, una T, una R... Non solo. Modificherà pure il valore delle singole parti. La R, per esempio, farà sì che le zeta diventino dolci, mentre le altre consonanti le renderanno dure. Se questa prima lettera fosse già presente, la parola si configurerebbe nella propria interezza e costituirebbe uno stimolo saturo, del quale solo sarebbe dato di prendere atto come dato comunicativo definito e chiuso. Ma poiché non è presente, siamo spinti ad operare processi inferenziali sulla base degli stimoli disponibili. In ogni raffigurazione (verbale o visiva) è tanto importante quel che c'è quanto quel che non c'è, o è appena fuori campo.
Proviamo a ridurre le informazioni del nostro engramma:
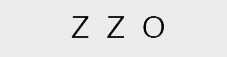
Le potenzialità di significazione si ampliano enormemente. Mentre prima, OZZO, spingeva verso la costituzione di alcune gestalt date dalle iniziali P, T, R, M, S. Adesso lo stimolo si apre a tutta una serie di nuovi significati possibili. La nuova forma può determinarsi come: mezzo, pezzo, pazzo, lazzo, razzo, pizzo... oltre a quelle già disponibili in precedenza. L’insaturità amplia la gamma interpretativa riducendo proporzionalmente l’efficacia definitoria dello stimolo iniziale. Più lo stimolo (testo o immagine) diventa insaturo, più amplia le proprie potenzialità interpretative.
Fino a un certo punto, però. C’è una soglia oltre la quale l’insaturo produce confusione e la mente non è più sollecitata al pensiero ma resta intrappolata nella indeterminatezza e nell’impotenza.
Sottraiamo ancora informazioni al nostro engramma:

Il testo, adesso espandibile in ogni senso, perde fatalmente ogni capacità evocativa. L’eccesso di libertà interpretativa soffoca l’attivazione del pensiero, tanto quanto farebbe un testo ipersaturo. Nell’uno e nell’altro caso il testo (la foto) perde la propria valenza creativa, promotrice di pensiero, e la fruizione rischia di diventare frustrante e immobilizzante.
L’autore d’arte, sia esso uno scrittore o un fotografo, deve imparare a muoversi in quest’area di mezzo, “transizionale” e creativa, variamente distante fra il troppo saturo e il troppo insaturo, senza mai eccedere nell’uno o nell’altro, ma, se la propria opera vuole diventare volano di nuovi contenuti possibili, deve prevedere sempre un sottile “fuori campo”, uno sfuocato, un elemento di indeterminatezza o di mistero.
Credo che la possibilità che una fotografia offre al fruitore di ricomporre in gestalt percettive coerenti le diverse parti dell’immagine, comprese quelle assenti, permettendo loro di veicolare significati ed emozioni, dia la misura del valore di quell’opera, ben al di là della oggettiva correttezza formale con la quale sono disposti gli elementi visibili.
Analogamente, l'incompletezza di alcuni elementi all’interno del fotogramma non riduce necessariamente il loro potere significante. Ci sono contenuti la cui natura semantica rimane integra anche se privati di pezzi significativi della loro massa. Per contro, elementi ripresi con ossessiva cura per la completezza rischiano di sbilanciare l'immagine, donando centralità a figure narrativamente destinate allo sfondo, e viceversa. Il danno diventa irreparabile quando l’ansia di completezza porta a far coincidere i confini di un determinato elemento con i bordi del fotogramma. È una di quelle rarissime condizioni, come dirò più avanti, che mi spinge a bocciare preventivamente e, lo ammetto, pregiudizialmente, una fotografia.
Equilibrio e squilibrio, all’interno di un’armonia gestaltica, sono elementi creativi utilizzabili dall’autore per tradurre i propri stati d’animo e altri determinarne nel fruitore. Quando parliamo di equilibrio tra gli elementi dell'immagine, dobbiamo sempre far riferimento al “peso specifico” di tali elementi. Esso va calcolato non soltanto in base all'ampiezza della porzione occupata, ma anche alla sua componente semantica: elementi dimensionalmente piccoli posti a margine del fotogramma, se di forte impatto emozionale, possono compensare adeguatamente la presenza di masse ben più ingombranti poste nel margine opposto, realizzando armonie perfette sul piano percettivo, anche se apparentemente squilibrate su quello geometrico.
Questa considerazione aprirebbe al discorso sulla simmetria, una forma speciale di equilibrio, importante (si pensi che anche l’orizzonte dritto è simmetria) ma non certo indispensabile, stante che immagini fortemente asimmetriche (penso a certe foto di Antoine D’Agata, tanto per nominarne uno) amplificano proprio per questa caratteristica la propria valenza espressiva. Un altro di quegli elementi da utilizzare cum grano salis, come strumento di linguaggio e non come dogma.
Quali sono, dunque, i modi in cui è possibile leggere una fotografia? Esiste uno “stile” di lettura e approccio critico all'immagine? Certamente sì.
Alcuni di noi valutano per prima cosa il dato tecnico: l’equilibrio tra le masse, la completezza della gamma tonale, la qualità dei grigi o del colore, l’eventuale presenza di dominanti, le alteluci leggibili, le ombre aperte, il rispetto della regola dei terzi, la qualità dello sfuocato, l’assenza di distorsioni, l'orizzonte dritto, i piedi non tagliati… Qualcuno punta dritto ai significati, commenta il fatto in sé mostrato dalla fotografia e valuta questa in base alla sua proprietà di raccontare quel fatto, descrivendolo nel dettaglio. Altri guardano alla capacità della fotografia di suscitare emozioni ed evocare immagini mentali, ricordi, fantasie e sogni. La tecnica in questo caso passa in secondo piano, la foto è considerata riuscita solo in virtù del fatto che riesca a fecondare l’immaginario personale e/o collettivo dei fruitori. Personalmente mi trovo molto in questo approccio, ma non sottovaluto affatto gli altri. Si tratta in fondo della ben nota dialettica barthesiana tra “punctum” e “studium” (4), per me l’uno non esclude l’altro. Amo e utilizzo spesso l’approccio di chi, anziché esprimere un giudizio di valore, costruisce una narrazione a partire dall'immagine. Una storia, un racconto, una reminiscenza, una fantasia, stimolata dall'immagine ma non per forza legata ad essa. Ci sono fotografie che si prestano particolarmente a questo tipo di lettura all’insegna della compartecipazione narrativa – mentre altre chiamano ad una visione più passivizzante -, è un modo indiretto e significativo di riconoscer loro valore da parte dell’osservatore, al punto di assorbirle, farle proprie, dar loro accesso al proprio immaginario e, da lì, ampliare i significati di quella proposta. Un modo esplicito di contribuire a quella che io chiamo la cocostruzione dei significati di un'opera.
Si potrebbe pensare che questo modo di leggere l'immagine sovrasti a volte l'intentio auctoris del fotografo, e quindi risulti sovrabbondante e “soffocante” rispetto all'opera. In realtà è una dinamica che avviene più spesso di quanto pensiamo: qualunque processo appercettivo innesca un pensiero, emotivo o razionale che sia, ed è il modo in cui l'immagine vive attraverso il fruitore, anche a distanza di anni, anche quando l'autore non è più in vita, ed espande i propri significati a volte anche ben oltre quelli presenti, magari solo in forma larvale, nella mente del fotografo. Questo può avvenire a patto che la foto non sia “pornografica”, nell’accezione già accennata. Pornografia, per me, non è ciò che mette in mostra l'osceno, ma è ciò che blocca il pensiero. Il troppo saturo è pornografia, a prescindere dai contenuti. E può esserlo, talvolta, per eccesso di “bellezza”.
Queste modalità di approccio sono tutte legittime e utili, spesso complementari. In realtà, quando ci sia buona conoscenza reciproca e assiduità di scambi all'interno di un gruppo, può bastare anche solo il tanto vituperato e laconico “mi piace” - o “non mi piace” - per avere un'idea sufficientemente precisa di quel che il nostro amico critico in quel momento vuol dirci, che sia un rilievo tecnico, un apprezzamento contenutistico o un'espressione emozionale. Ma è pur vero che ogni parola aggiunta, sia una critica negativa o un elogio, è indubbiamente un dono supplementare, di cui essere grati sempre, perché l’osservatore spende un po’ del suo tempo per focalizzare e descrivere la sua reazione di fronte all'immagine, e si espone pure a eventuali controcritiche, anch'esse faticose e feconde: credo infatti che il pieno rispetto di un commento non stia nell'accettarlo passivamente, ma nel recepirlo, farlo proprio e poi, eventualmente, controargomentarlo. Così si cresce insieme, autori e fruitori.
Dicevamo prima come sia necessaria una “cultura” per comprendere appieno un’opera. E senza cultura cosa si fa, si rinuncia a commentare? Un antico aforisma, di cui purtroppo non ricordo le origini, dice che la cultura è come il vino in un otre: più se ne ha e più si espande l’otre... Per dire che non c’è mai un livello di conoscenza sufficiente a colmare la voglia e la necessità di sapere; conoscere conduce a rendersi consapevoli di quanto poco si sappia, non il contrario. Cosa facciamo di fronte ad un’opera che non comprendiamo? Potrebbe semplicemente non piacerci, e allora non abbiamo che da dirlo: “non la comprerei”, piace dire a me. Ma ci sono foto che non comprendiamo e che eppure ci interrogano, foss’anche solo per la stima che abbiamo del loro autore. In questi casi potrebbe essere una buona cosa lasciarsi “attraversare”, farsi ghermire dalle emozioni, abbandonarsi all’imponderabile, aprire nuovi varchi nella propria scorza difensiva razionale. Non credo che serva cercare a tutti i costi di scovare significati reconditi, a mo’ di novelli Sherlock Holmes, ma piuttosto provare a costruirne di nuovi, inventare una narrazione, una fantasia, uno scenario immaginario, consapevoli che stiamo lavorando a un’espansione di significati, a una compartecipazione nell’aratura del campo semantico dell’opera. Sempre che la fotografia sia in grado di fornire quella scintilla, ovviamente, in caso contrario, nel dubbio meglio tacere, oppure esprimere chiaramente la propria perplessità, e poi informarsi, cercare altre opere di quell’autore, provare a individuarne la linea poetica in una prospettiva più ampia.
Do per inteso che stiamo parlando di foto a vario titolo “autoriali”; nei forum e nei circoli c’è ovviamente chi propone foto solo per ricevere un parere tecnico, ed è tutto un altro discorso.
Ancora un inciso per ricordare che una proposta può essere costituita da più foto, una serie, uno studio, un reportage. Valgono in linea di massima le considerazioni fatte per la singola foto, sapendo però che il significato complessivo va cercato all'interno di un corpus più ampio, che può assumere la cadenza del racconto, con un ordine cronologico, una trama o un crescendo di tensione, oppure svilupparsi per flash singoli eppure interconnessi.
Il discorso sulle serie meriterebbe una riflessione a parte.
Così come la merita il tema del titolo e del suo ruolo. Si dice spesso che la foto deve essere autosufficiente, raccontarsi da sé. È vero, ma secondo me solo in parte. Un titolo non è per forza qualcosa di esplicativo o didascalico. Il titolo può spiegare in alcuni casi, indirizzare la lettura, ma in altri può avere la funzione di sedurre, incuriosire, ingannare, provocare, operare travisamenti ironici, espansioni del senso e persino il suo ribaltamento. Il titolo può lavorare a contestualizzare un'immagine, accompagnarla oppure diventarne complemento, in un gioco intrigante tra immagine e testo. Quel che a mio avviso non dovrebbe mai fare è “sostituirsi” all'immagine, in tutto o in parte. Allora sì che il titolo diventa una presenza invadente, una excusatio non petita che immediatamente denuncia una debolezza della foto e una fragilità nelle intenzioni del suo autore.
Se noi pensiamo alla fotografia come a un linguaggio, allora dobbiamo accettare che anch’essa, per rendersi più efficace, debba fare ricorso a una quantità di regole sintattiche, osservate sia in fase di ripresa che nella post, attraverso gli strumenti propri dell’arte fotografica (fuoco selettivo, bruciature, mascherature ecc.). Della punteggiatura abbiamo detto, poi ci sono le accentature, i virgolettati e persino la consecutio temporum, lì dove, per esempio, può capitare di incontrare foto di piana quotidianità domestica trattate, incongruamente, con stile degno di qualche sanguinoso evento storico… Occorre la massima attenzione alla coerenza tra registro linguistico, scelte tecniche e messaggio.
Trovo particolarmente interessante considerare l’utilizzo delle figure retoriche. Esse sono la struttura portante del linguaggio, anche quello fotografico, facilitano l’espressione di concetti complessi e amplificano la forza persuasiva del messaggio. Rappresentano la possibilità di mediare tra l’idea e la sua espressione, veicolando il concetto verso la sua dimensione simbolica. In fotografia ne utilizziamo continuamente, spesso senza rendercene conto. Di fatto, è proprio l’individuazione, talvolta inconsapevole, di queste strutture che ci spinge istintivamente allo scatto, allenati come siamo a notare ripetizioni, similitudini, chiasmi, allegorie, e a utilizzare, nella composizione o nella scelta del punto di ripresa, metafore, enfasi o litoti, magari senza sapere che si chiamano così. D’altronde, non c’è bisogno di conoscerle nel dettaglio, né da parte del fotografo né da quello del fruitore, basti sapere che la capacità pur istintiva di utilizzare tali figure può rendere il messaggio significativamente più forte. L’occhio esperto del fotografo le individua al volo, tanto quanto l’occhio dell’osservatore le coglie e ne fa motivo di gradimento dell’immagine.
Riepilogando.
La realizzazione di una fotografia si confronta con alcune regole precise e codificate: la regola dei terzi, la sezione aurea, la massima ampiezza della gamma tonale, la nitidezza, il rapporto figura sfondo, l'orizzonte dritto, l'equilibrio tra le masse, l'ordinata scansione dei soggetti, ecc. Com'è ovvio, esse costituiscono solo alcuni dei criteri di validità di una foto. Se bastasse rispettare alcune regole per fare ottime fotografie, avremmo tutti la ricetta servita per diventare HCB o Kertész...
È il modo di farle proprie, interpretarle, trasgredirle in tutto o in parte, ma sempre in modo misurato e consapevole, che permette all'autore di modulare in maniera originale le potenzialità espressive della propria opera.
Ogni aspetto legato alla forma, a meno di non rifarsi ad un generico ideale di bellezza sempiterna, va comunque letto all’interno di un percorso riconoscibile di senso, valutando la coerenza interna della singola immagine, quella all’interno di un definito stile del fotografo, il richiamo ad una corrente artistica o ad un autore di riferimento, la capacità evocativa e narrativa di una fotografia e la sua capacità di suscitare emozioni.
Su tutto si imporrà comunque, alla fine, il gusto personale, che tutto quanto comprende e trascende.
A questo proposito, faccio outing su quelle che sono ad oggi alcune mie irremovibili idiosincrasie. Non sono molte, cito le due principali: 1) come ho già detto, mi dispongono negativamente le foto in cui gli elementi, magari in ossequio ad un’ansia di “interezza”, vengono collocati in modo da lambire il bordo del fotogramma (peggio ancora le linee che finiscono sugli spigoli); 2) considero inaccettabili le foto in cui pali, lampioni e altri elementi di disturbo “fuoriescono” dal corpo di uno dei soggetti.
Si comprende facilmente come per me la cura per lo sfondo e i dettagli “marginali” sia un aspetto di fondamentale importanza, quasi più dell’attenzione riservata al soggetto in primo piano.
A conclusione di questa breve disamina, ricorderò a tutti noi una verità banale: è assai più semplice esercitare una buona critica nei confronti di opere altrui che delle proprie. Troppo forte il coinvolgimento, tale da influenzare inevitabilmente il nostro giudizio sui nostri scatti. Può aiutare il tempo, la possibilità di lasciar depositare le sensazioni, rivisitando le nostre fotografie in un adeguato a posteriori. Ma meglio ancora, specie in caso di esposizioni o pubblicazioni importanti, funziona la consultazione di un editor esterno, una persona fidata e sufficientemente “sfrontata”, capace di esprimere in piena obiettività e senza soggezione giudizi anche crudeli. Va bene anche il confronto con gli amici di circolo o di forum, sempre che si superino le remore, la paura di dare delusioni o di subire ritorsioni.
Anche per questo, spero che questi miei pensieri potranno aiutare ad un esercizio della critica più ragionato ma anche più disinvolto, e che ad essi possano seguire le riflessioni di altri amici, ad ampliare, supportare o criticare le mie. Un modo di lavorare insieme per conquistarci il massimo di libertà espressiva possibile, quella a cui le nostre modeste genialità ci permetteranno di ambire.
(1) A. Feininger, La fotografia: principi di composizione. Vallardi, 1979
(2) C. Riggi, Di lemmi fotografici. Dizionario sragionato di Fotografia. Ilmiolibro.it, 2015
(3) La Teoria della Gestalt, detta anche Psicologia della Forma, è una corrente teorica sviluppatasi in Germania nei primi anni del '900, focalizzata sui temi della percezione e dell'esperienza. Suoi massimi esponenti furono W. Köhler, M. Wertheimer e K. Koffka. In Italia F. Metelli e G. Kanizsa.
(4) R. Barthes, La camera chiara. Nota sulla fotografia. Einaudi, 2003